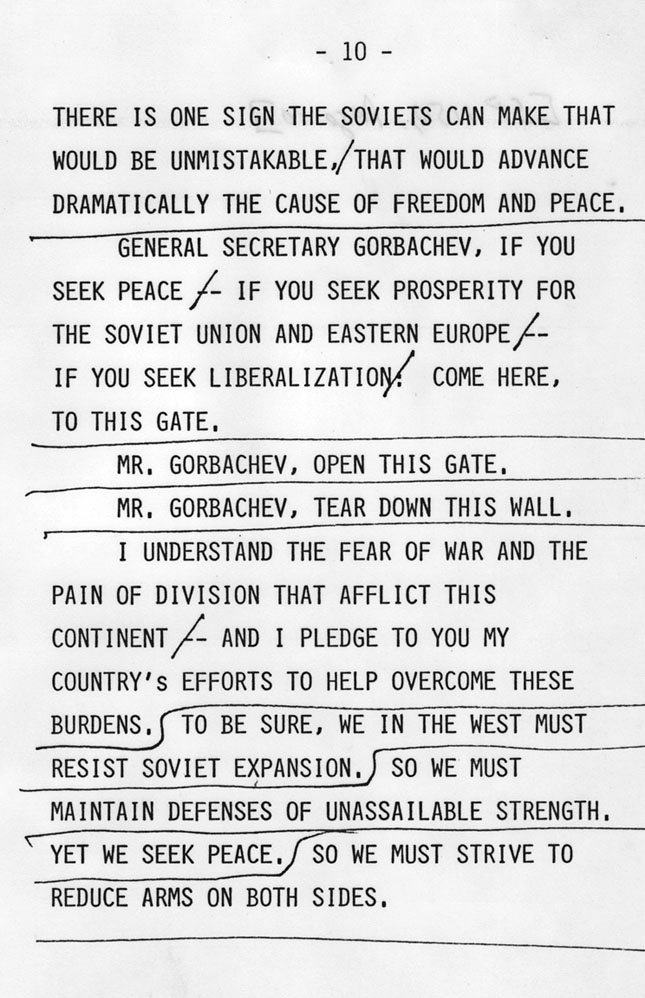E così alla fine la fatidica sentenza è arrivata, e che botto ha fatto: "ObamaCare", la più importante delle riforme attuate dall'amministrazione Obama (anche a costo di lasciarne da parte altre di importanti sulle quali il presidente ha scelto di darle la priorità), è salva.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha smentito clamorosamente tutti (ma proprio tutti) i pronostici (per tacere della "anticipazione" sbagliata della CNN, che resterà agli annali nella top ten delle gaffe giornalistiche), con un voto a maggioranza risicata 5 contro 4 nel quale - e questo è il dato veramente eclatante, che ha lasciato tutti i commentatori e gli "esperti" a dir poco in mutande - a fare da ago della bilancia per una volta non è stato il giudice Kennedy, eterna banderuola che invece stavolta ha votato con i tre conservatori Scalia, Alito e Thomas ed ha letto la propria opinione dissenziente, bensì il presidente della Corte John Roberts. Proprio lui: il conservatore nominato da Bush, che si è schierato con i quattro giudici dell'ala progressista.
Con questo insolito assetto, la Corte ha giudicato costituzionalmente legittima tutta la legge, inclusa la controversa obbligatorietà della assicurazione sanitaria per tutti i cittadini che è stata considerata legittima perché in fondo, secondo i giudici, basta considerarla come una sorta di tassa sul mancato acquisto della polizza: le tasse il parlamento federale ha tutto il potere di imporle, senza per questo travalicare i confini della autonomia dei singoli Stati membri.
Uno strano processo davvero quello conclusosi oggi, che ha visto l'Amministrazione Obama difendere come un proprio caposaldo la riforma che Obama aveva fatto faticosamente approvare dopo aver detto in campagna elettorale che non l'avrebbe fatta... e mentre a tifare con tutte le forze per l'annullamento ci sono stati i repubblicani che, a loro volta, la detestano visceralmente ma contro Obama hanno pensato bene di candidare proprio il politico cui Obama si è ispirato per questa riforma.
Facciamo un passo indietro. Nell'ottobre del 2006, TIME uscì con un'edizione incentrata su una sorta di consacrazione profetica: il titolo di copertina era “Why BarackObama could be THE NEXT PRESIDENT”, e il principale articolo su quella cover-story era un lungo reportage di Joe Klein, intitolato "The Fresh Face", tutto dedicato a quello che all'epoca era solo un giovane senatore dell'Illinois, che nel pezzo veniva intervistato in lungo e in largo. A un certo punto dell'intervista, Klein - pensa un po' gli scherzi del destino - pensò bene di chiedere ad Obama un parere sulla riforma del sistema sanitario locale che uno dei possibili candidati repubblicani alla Casa Bianca, Mitt Romney, aveva fatto approvare da Governatore del Massachusetts. La riforma sanitaria di Romney ("RomneyCare", nel politichese USA) prevedeva (e prevede tutt'ora) che chi ha un reddito almeno triplo rispetto alla soglia di povertà sia tenuto per legge a dotarsi ()a proprie spese di una polizza di assicurazione sanitaria a proprie spese, mentre chi ha un reddito al di sotto di quella soglia riceve dallo Stato un apposito sussidio. Questa obbligatorietà (mandate) della assicurazione veniva contestata come sopruso statalista da molti repubblicani, ma Romney, che governava dal centro uno Stato tradizionalmente liberal, la aveva voluta a tutti costi introdurre, d'accordo con il più illustre politico di là, il senatore democratico Ted Kennedy. Klein aveva pensato la domanda sul tema anche per questo: all'epoca Obama si era fatto notare soprattutto per uno stile notevolmente bipartisan, per una frequente ricerca di compromessi che trascendessero i tradizionali steccati ideologici tra democratici e repubblicani. Ma la domanda venne formulata andando a parare proprio sulla controversa questione della obbligatorietà, che secondo Klein era una buona idea. L'esito fu il seguente:
Obama non mi ha seguito fino a lì. "Se esiste un modo per arrivarci volontariamente, ciò è più consono alla mentalità americana" mi ha detto. "Solo se proprio non riesci a risolvere il problema senza che la autorità statale si intrometta, allora ricorri ad un obbligo".
Nel 2008, in campagna elettorale per la conquista della Casa Bianca, il senatore dell'Illinois promise di imporre alle compagnie di assicurazione di accettare tutti gli aspiranti assicurati, e di creare una alternativa statale per fare concorrenza al ribasso e così far scendere il prezzo delle polizze (la famosa public option che il Congresso avrebbe infine bocciato); ma non smentì mai di non vedere di buon occhio un obbligo di assicurarsi.
Ciò nondimeno, quando all'inizio del suo mandato presidenziale decise di prendere quel toro per le corna mandò i suoi consulenti a studiarsi proprio "RomneyCare" come prototipo per la riforma nazionale; e infatti anche "ObamaCare" (ufficialmente la legge di riforma del sistema sanitario nazionale si chiama "Affordable Care Act": ObamaCare all'inizio lo usavano solo i repubblicani ma con il tempo è divenuto di uso comune e quest'anno è stato "sdoganato" da David Axelrod, il guru elettorale di Obama, ed utilizzato nella campagna per la rielezione del presidente) contiene un mandate, l'obbligo per ciascun cittadino di assicurarsi (comunque presso compagnie di assicurazione private, non essendo mai stato introdotto un servizio sanitario nazionale statale per tutti: quello rimane riservato agli anziani e ai poveri). Ciò a proprie spese se si guadagna almeno il quadruplo del reddito assunto come soglia di povertà; altrimenti grazie a sussidi statali. Chi non si assicura si becca una multa (penalty) talmente salata da rendere più economico l'acquisto di una polizza.
Proprio su questa questione della multa si è tanto dibattuto in questi due anni, e proprio su questo la Corte Suprema ha oggi chiuso la discussione: chiamiamola tassa e non multa, e facciamola finita.
Il che implica un altro paradosso: nel 2009, era stato lo stesso presidente, intervistato in una popolare trasmissione televisiva, a smentire con molta fermezza la teoria della "tassa" ("anche l'assicurazione dell'auto è obbligatoria, eppure nessuno si sogna di chiamarla tassa... i miei avversari mi accusano di aumentare le tasse facendo approvare questa riforma, ma quelli mi accusano di aumentare le tasse qualunque cosa io faccia..."). Ancora adesso se andate sul blog ufficiale della Casa Bianca trovate un post del 16 dicembre 2009 intitolato "La verità sulla riforma sanitaria e le tasse", che spiegava come l'approvazione della riforma non avrebbe introdotto alcuna nuova tassa (se non quella su una piccolissima nicchia di superpolizze per miliardari, la casiddetta "Cadillac tax").
Con questa sentenza si è concluso quello che è stato un vero processo a tappe forzate: le udienze si erano tenute alla fine di marzo in appena tre giorni, a tempo di record, ed oggi è giunto il Giorno del Giudizio. Ufficialmente ha vinto Obama, ed hanno perso i ben ventisei dei cinquanta Stati dell’Unione che avevano "fatto causa" contro il governo federale avendo contestato la legittimità costituzionale della legge; il capofila fu la Florida, che figura come il titolare della causa decisa oggi (è formalmente protocollata come "Stato della Florida ed altri contro Ministero della Salute").
Il che implica un altro paradosso: nel 2009, era stato lo stesso presidente, intervistato in una popolare trasmissione televisiva, a smentire con molta fermezza la teoria della "tassa" ("anche l'assicurazione dell'auto è obbligatoria, eppure nessuno si sogna di chiamarla tassa... i miei avversari mi accusano di aumentare le tasse facendo approvare questa riforma, ma quelli mi accusano di aumentare le tasse qualunque cosa io faccia..."). Ancora adesso se andate sul blog ufficiale della Casa Bianca trovate un post del 16 dicembre 2009 intitolato "La verità sulla riforma sanitaria e le tasse", che spiegava come l'approvazione della riforma non avrebbe introdotto alcuna nuova tassa (se non quella su una piccolissima nicchia di superpolizze per miliardari, la casiddetta "Cadillac tax").
Con questa sentenza si è concluso quello che è stato un vero processo a tappe forzate: le udienze si erano tenute alla fine di marzo in appena tre giorni, a tempo di record, ed oggi è giunto il Giorno del Giudizio. Ufficialmente ha vinto Obama, ed hanno perso i ben ventisei dei cinquanta Stati dell’Unione che avevano "fatto causa" contro il governo federale avendo contestato la legittimità costituzionale della legge; il capofila fu la Florida, che figura come il titolare della causa decisa oggi (è formalmente protocollata come "Stato della Florida ed altri contro Ministero della Salute").
E Romney? Dal canto suo, lo sfidante repubblicano si è sempre rifiutato di rinnegare come un errore la riforma da lui fatta in Massachussetts; egli promette però di far abrogare, se eletto, quella nazionale voluta da Obama, benché di fatto pressoché identica alla sua- Per il più ovvio dei motivi: in questi due anni tutti i sondaggi hanno dato la maggioranza assoluta degli americani, quindi non solo i repubblicani ma anche gli indipendenti, ostile alla legge.
E così da oggi a quei cittadini americani che continuano a detestare questa riforma, a trovarla moralmente ingiusta ed economicamente insostenibile per le loro tasche in questi anni di recessione e di disoccupazione, non resta altra opzione, per tentare di sbarazzarsene, che votare - ironia della sorte - contro la rielezione di Obama e - ironia della sorte - a favore di quel candidato cui si deve la attuazione del caso-pilota di assicurazione obbligatoria, il quale però oggi più che mai potrà raccogliere consensi promettendo il “repeal and replace” , la abrogazione della legge e la sua sostituzione con un'altra. Con quale, poi? Non è ben chiaro, per ora. A me però torna in mente la profezia che un redattore dell'Economist sparò giusto un anno fa sul suo blog:
La mia ipotesi è che [una presidenza Romney] renderebbe permanente la riforma sanitaria di Barack Obama, limitandosi a qualche modifica "foglia di fico" che consentirebbe a Romney di rivendicare di aver annullato l'odiata ObamaCare e di averla sostituita con una riforma alternativa repubblicana... che però in realtà sarebbe sostanzialmente uguale.
Staremo a vedere. Intanto, il testo integrale della sentenza è online a questo link: buona lettura ai volonterosi ;)
UPDATE - Commento a caldo di Romney: "Se vogliamo sbarazzarci di questa legge, l'unico modo è rimpiazzare Obama". Ecchelollà.
UPDATE - Commento a caldo di Romney: "Se vogliamo sbarazzarci di questa legge, l'unico modo è rimpiazzare Obama". Ecchelollà.